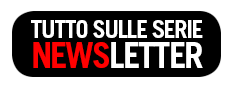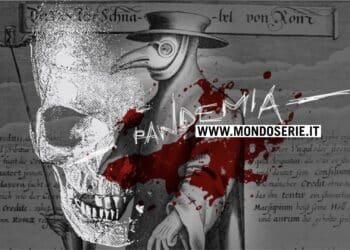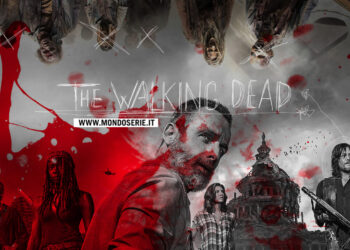Gamers, geek e nerd (cioè, ormai, la gran parte di noi, per una ragione o per l’altra) hanno subito trovato Mythic Quest irresistibile, con la sua riuscitissima ambientazione nell’industria videoludica. Ma la serie è risultata più che piacevole, con i suoi tratti da sitcom da ufficio ritmata e non banale, anche ai non appassionati di videogame. Cioè, come diremo meglio dopo, l’industria dell’intrattenimento con il maggior tasso di crescita da parecchi anni a questa parte.
Lo show, lanciato in sordina da Apple TV+ a inizio 2020, si è rapidamente conquistato non solo un pubblico fedele ma anche un solido apprezzamento critico. Grazie a una felice idea di partenza, sviluppata con intelligenza e umorismo e magnificamente interpretata. Riuscendo anche a crescere, dopo un brillantissimo debutto, con una seconda stagione davvero ottima. Capace di raggiungere profondità non banali, e di guadagnare così il rinnovo per altri due capitoli.
Tutto bene, quindi? Come fa intendere il titolo dell’articolo, non proprio. La terza stagione di Mythic Quest, chiusasi a inizio 2023, ha segna un deciso arretramento. La quarta, conclusa a marzo 2025 con l’episodio 40 dello show, ha visto il declino proseguire. Al punto da far dubitare del giudizio complessivo. E l’incertezza produttiva non migliora il quadro: visto che al momento non è ancora chiaro se la serie proseguirà. O se il bolso finale della stagione 4 sarà anche la parola fine su una serie partita bene, proseguita meglio, e poi misteriosamente arenatasi nelle secche della mancanza di ispirazione.
Ma andiamo con ordine.
Di che parla Mythic Quest
Mythic Quest (nella prima stagione Mythic Quest: Raven’s Banquet), creata da Charlie Day, Megan Ganz e Rob McElhenney, ha debuttato il 7 febbraio 2020. Lo show racconta di uno studio di videogiochi che produce Mythic Quest, popolarissimo MMORPG. E cioè uno di quei mega giochi di ruolo multi giocatore in rete, di solito fantasy, capaci di portare milioni di persone a condividere lo stesso universo. Un esempio molto noto è World of Warcraft, gioco della Blizzard che ha dominato per un sacco di tempo il settore. E che ispira la sua controparte di finzione, appunto Mythic Quest.
Lo studio è dominato dal creatore e direttore creativo del gioco, Ian Grimm (Rob McElhenney, co-autore dello show). Egocentrico e narcisista, Grimm vive conflitti costanti con il resto dello studio e con un mondo esterno di giocatori invasati, haters, rivali, influencers prezzolati. All’inizio della serie, lo studio sta per pubblicare un’importante espansione al gioco: Raven’s Banquet.
Le altre figure chiave sono la nevrotica ingegnere capo Poppy Li (Charlotte Nicdao), l’inetto produttore esecutivo David Brittlesbee (David Hornsby), il cinico responsabile finanziario e commerciale Brad Bakshi (il fantastico Danny Pudi, amatissimo in Community) e lo stralunato e inaffidabile capo sceneggiatore C.W. Longbottom (il grandissimo F. Murray Abraham).
È quest’ultimo, in un mondo fatuo a vanaglorioso, il personaggio migliore, affidato a un attore finissimo come Abraham, che tutti ricordiamo come il Salieri di Amadeus. Qui nei panni di uno scrittore di fantascienza alcolizzato e fallito, riciclatosi come responsabile della linea narrativa del gioco, che cerca costantemente di arricchire di esilaranti quanto ridicoli retroscena (backstory). Se avete amato il suo personaggio di patriarca italo-americano nella stagione 2 di The White Lotus, ecco: qui trovate un altro esempio televisivo della verve comica di un attore più noto per i suoi “cattivi”.
Le stagioni 1-2, l’uso creativo della quarantena e le guest star
Nelle prime due stagioni (2020-2021), Mythic Quest ha messo in campo 20 episodi di circa 30 minuti ciascuno. Con una curiosa distribuzione: 9 episodi nella prima stagione, 9 nella seconda, e 2 episodi speciali in mezzo.
“Quarantine”, realizzato e ambientato durante i primissimi mesi della pandemia, è stato forse anche il primo esempio di uno show capace di fare un uso creativo dei limiti e dei vincoli della quarantena eponima. L’episodio in questione è uscito il 22 maggio 2020: appunto, nel pieno del primo lockdown più o meno globale. Ed è stato scritto, girato e montato in sole tre settimane, tutto da remoto, utilizzando solo iPhone e altri prodotti Apple.
La pandemia fa quindi la sua apparizione in una commedia tv. E per l’appunto in una commedia che racconta il mondo di un ufficio: sede di un’industria creativa, ok, ma qualcosa di tutto sommato vicino all’esperienza di quasi tutti. “Quarantine”, con i suoi collegamenti a distanza e il suo senso palpabile di precarietà e di ansia, nonostante il desiderio di provare a sorriderci sopra, ci ricorda come ci sentivamo nella prima primavera da Covid-19. Isolati nelle videoconnessioni, spaesati, ma in fondo ancora speranzosi.
Il secondo speciale, “Everlight”, ha anticipato di poche settimane l’inizio della stagione 2 di Mythic Quest, nella primavera 2021. Vi appare come narratore il sommo Anthony Hopkins. Primo di una parata di guest star che illuminano la seconda stagione. Da Snoop Dogg a Cristin Milioti a William Hurt, e che contribuiscono all’ottima resa del secondo capitolo.
La terza, deludente stagione di Mythic Quest
La terza stagione di Mythic Quest, altri 10 episodi distribuiti da fine 2022, ha invece deluso. E molto. Tanto da farci dubitare della direzione complessiva di uno show piccolo ma che ci era tanto piaciuto. Cos’è che non ha funzionato?
Partiamo dai fondamentali. La strana scelta di spezzare l’unità d’azione, forse dovuta al timore della ripetizione, non paga. Anzi. Ian Grimm e Poppy Li mollano lo studio che avevano fatto grande per fondarne uno nuovo, GrimPop. Alle spalle si lasciano non solo il videogioco eponimo ma anche il film che si è deciso di produrne. E di cui si dovrà occupare l’insicuro David, diventato capo della società – capo sul serio, stavolta, non solo sulla carta.
Ma creare due nuclei narrativi e dialettici distinti (il mondo di Mythic Quest, il mondo della neonata GrimPop) non aumenta le opportunità narrative o comiche. Anzi. Il primo, quello della “vecchia” azienda, è bloccato nella ripetizione di schemi già visti – ma meno divertenti, vista l’assenza di diversi motori. Il secondo vorrebbe raccontare la difficoltà di dar vita a un nuovo prodotto di successo, ma finisce per diventare una sorta di sitcom di coppia tra i due nevrotici protagonisti.
Non aiuta neppure il cambiamento complessivo nel peso dei personaggi. Esce di scena il Longbottom di Abraham (il che, lo avete capito, è per noi una tragedia). È ridotto il personaggio di Danny Pudi, pure sempre capace di guizzi. Cresce invece la presenza di personaggi che vorrebbero satireggiare i temi dell’inclusività, del politicamente corretto e della forced diversity, ma che finiscono invece per esserne applicazioni quasi sempre piatte: Carol (Naomi Ekperigin), capa delle risorse umane e poi appunto della divisione “diversità e inclusione”; le due lesbiche ed ex tester Rachel (Ashly Burch) e Dana (Imani Hakim), più irritanti che inutili.
Il disastro quasi totale della stagione 4
Insomma, lo avete capito. Aspettavamo la stagione 4 di Mythic Quest con la speranza che la serie sarebbe tornata a ruggire. O, insomma, almeno a farci sorridere. Piacerebbe poter dire che la lunga attesa è stata ripagata. Ma non è così. Uscito a inizio 2025, a più di due anni di distanza dalla fine della stagione 3, il nuovo capitolo continua la spirale discendente già registrata nel precedente atto.
L’azione continua a soffrire di una frammentazione che non è tanto episodica quanto proprio sconclusionata. I personaggi minori continuano a guadagnare spazio, ma fanno solo rimpiangere le vecchie dinamiche. La relazione sentimentale avviata dalla workaholic Poppy finisce per allontanarla ancora di più non solo dal narcisistico Ian, ma anche dallo studio. I due protagonisti, già motore dell’azione comica, danno vita a un piuttosto estenuante percorso di confronto, che dovrebbe portarli – entrambi – a maturare e crescere. Ma perché dovrebbe importarci che il personaggio di una sitcom maturi? Peggio: perché mai dovrebbe cambiare? È forse tutto qui il problema della Mythic Quest dopo le stagioni 1 e 2: un fraintendimento su cosa funzionasse. Sulla propria natura.
Certo, qua e là ci sono ancora spunti efficaci, momenti riusciti. L’audizione dei rappresentanti dell’industria videoludica davanti al Congresso americano che si trasforma in un disastro (con qualche punzecchiatura sul lavoro minorile, problema anche di questo settore). O l’episodio che adatta un vecchio classico di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, con più di una perla.
Anche se il meglio arriva quasi in fondo, all’episodio 9 (diretto dal nostro amato Danny Pudi). Il capo dello studio, David, in riunione con tutto lo staff rievoca i bei tempi del Covid, momento magico per gli affari videoludici. Con tanto di canzoncina e balletto su quanto bella sia stata la pandemia.
L’industria dei videogame, la sua satira… e il Covid
La scena succitata ci porta a un tema interessante. Dicevamo all’inizio che l’industria videoludica è, tra quelle dell’intrattenimento, quella in maggior crescita. Nel 2020, il mercato globale dei videogiochi ha stimato un fatturato annuo di 159 miliardi di dollari tra hardware, software e servizi: grazie alla pandemia, e quindi alla crescita dell’intrattenimento digitale e domestico, si è registrato uno sbalorditivo +23%. Tre volte la dimensione dell’industria musicale globale e quattro volte quella dell’industria cinematografica del 2019. Complici le nuove possibilità offerte dalla trasformazione in piattaforme ludiche anche dell’oggetto tecnologico per eccellenza del nostro tempo, lo smartphone, la stima è che entro il 2026 si superino i 200 miliardi di dollari di business.
Dell’industria del gaming, lo show è una arguta (ma affettuosa) satira. Che ne mette alla berlina le dinamiche interne, lo schiavismo verso i reparti grafici e tecnici, il sessismo, gli stereotipi, l’avidità commerciale che perverte la creatività primigenia.
Ma se il Covid ha fatto bene agli affari dell’industria videoludica, non altrettanto bene ha portato alla produzione di Mythic Quest. Che ne ha vissute di cotte e di crude. A parte il già menzionato episodio speciale “Quarantine”, la produzione della seconda stagione è stata un vero calvario. Sospesa, ripresa, sospesa di nuovo a causa dei continui test positivi di membri della troupe. Al punto che McElhenney dopo l’ennesima allerta ha detto, a inizio 2021, che “non voleva essere ricordato come la persona che ha fatto ammalare F. Murray Abraham”. Così, il personaggio di Abraham è apparso nello show solo in collegamento remoto fino al settimo episodio della seconda stagione. Quando l’attore ultra ottuagenario è potuto tornare sul set, in ambienti molto controllati e con troupe ridottissima.
Nel marzo 2021, Variety ha riferito che ben 26 membri del team di Mythic Quest si sono ammalati di Covid-19, rendendolo “il peggior focolaio di qualsiasi show a Los Angeles”. Curiosa nemesi virale per una serie tutta ambientata nel cuore della cultura digitale!
Mythic Quest: punti di forza e highlight
Gli episodi 6 e 7 della stagione 2, “Backstory!” e “Peter”, sono i migliori. Il primo racconta in un lungo e fiabesco flashback l’origine della carriera di C.W.. Giovane scrittore di nessuna abilità che grazie al fortuito incontro con il leggendario e prolifico Asimov riesce a emergere nel mondo della fantascienza. Il secondo racconta la riconciliazione tra C.W. e Peter, suo grande amico di 40 anni prima, quando erano entrambi aspiranti autori, e da cui si era seccamente separato. A sua volta scrittore di fantascienza di alterne fortune e non pochi rimpianti, Peter è interpretato nientemeno che dal compianto William Hurt.
Nota a margine: Rob McElhenney è noto come il creatore e uno dei protagonisti, anche qui con Charlie Day, della black comedy It’s Always Sunny in Philadelphia. Sitcom dark che in Italia è ancora pressoché sconosciuta. Ma che in America è in onda dal 2005: con 16 stagioni (e almeno altre due già confermate) è la più longeva commedia live action della storia della tv USA.
Per chiudere. Al di là del vostro interesse per il mondo dei videogame, Mythic Quest è (stata) un buon intrattenimento, ritmato, brioso, acuto. Capace di regalare episodi non solo oggettivamente spassosi ma a volte emozionanti. E sorprendenti per profondità, specie nella seconda stagione.
La terza stagione, si è detto, ha deluso. La quarta anche peggio. In attesa di sapere se proseguirà, continuiamo ad amare le prime due. Illuminate da ogni apparizione del premio Oscar F. Murray Abraham. Davvero meraviglioso nei panni dello scrittore alcolizzato e fallito che cerca di dipanare una linea narrativa che lui per primo non comprende. E di cui, soprattutto, non gliene può fregare di meno.
La sitcom da ufficio per eccellenza? The Office, di cui parliamo qui
The Office: i 20 anni di una grande satira dell’umanità al lavoro